Un 14 «volante»… Quattro partecipazioni di fila alle Olimpiadi… L’argento a Mosca… Una vita al Cantù, in campo anche a 54 anni… Presidente del Coni Lombardia…

Vedevi un «numero 14» volare. Coast to coast, veloce di palleggio e di gambe, l’entrata a canestro fulminea, o il passaggio smarcante sotto. Il contropiede era solo l’esibizione più appariscente del suo ricco – e per molti versi rivoluzionario – repertorio di play-maker. Quel numero di maglia si identificava in un nome; il nome, Pierluigi Marzorati, in quel numero. Cose che succedono solo ai campioni. Come lui è stato: di tecnica, di combattività, di correttezza anche. Ventidue anni sui parquet, e altrettanti di successi, vissuti per due sole squadre: Cantù (primo e unico amore come club) e Nazionale. Di entrambe sarebbe diventato un giocatore-simbolo; in entrambe, il suo numero 14 avrebbe lasciato il segno.
In un racconto sulle Olimpiadi non può passare inosservato, il suo è un ruolo da protagonista, con posto riservato nella sezione-record. Quattro partecipazioni consecutive, tra gli anni Settanta e Ottanta. Come lui, in Italia, solo Dino Meneghin; anzi con lui, insieme nello stesso percorso, a contrassegnare un’epoca. Li ritroviamo accanto anche in cima alla classifica relativa alle presenze in maglia azzurra; solo che Marzorati, in questo caso, la spunta per qualche lunghezza (278 a 271). Ci si guadagna in gloria già a condividere certi primati; figuriamoci ad averli tutti per sé. «Ne vado orgoglioso – confessa senza falsa modestia – e penso pure che siano dei record non più battibili. Lo dico anche con una punta di rammarico, perché ormai la Nazionale non gode più delle attenzioni di una volta…».
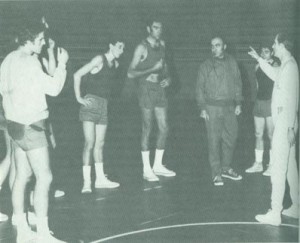
Parla al telefono dalla sede milanese del CONI Lombardia, di cui è presidente da quasi due anni. Ogni tanto è costretto a interrompere la comunicazione («Scusi un attimo…»), lo senti rispondere ad altre chiamate o dare disposizioni, poi ritorna («Eccomi, dicevamo…») e la chiacchierata va avanti. Impegnato e disponibile. Come sempre. Come quando divideva le ore della giornata tra i duri allenamenti e gli studi in Ingegneria (dovette solo rinunciare a un Europeo per conseguire la laurea; da allora, continuando a giocare ancora per dodici anni, fu soprannominato «l’ingegnere volante»); o come quando, già occupato dalla sua professione a progettare impianti civili e sportivi, prestava tempo e immagine per iniziative in favore dell’infanzia del mondo, in qualità di ambasciatore UNICEF.
Lo intratterremo solo sulla sua esperienza in Nazionale e su quella olimpica in particolare – ci premuriamo di rassicurarlo – altrimenti dovremmo trovare una pagina vuota di appuntamenti nella sua agenda se volessimo ripercorrere in lungo e in largo la sua carriera. Cominciamo dall’esordio con la maglia azzurra. Era il 21 agosto del 1971, Campionati Europei in Germania Ovest, partita vinta contro Israele, poi arrivò una medaglia di bronzo storica, primo podio dopo tanto anonimato. «Allora ero solo un ragazzino (19 anni n.d.r.) e poco più che un comprimario, ma per me fu come entrare in paradiso». C’erano vecchi marpioni come Masini, Flaborea, Recalcati, Bariviera, Bisson, lo stesso Meneghin, che aveva fatto il suo ingresso in squadra due anni prima. «Mi sentivo un po’ spaurito, cercavo di stare attaccato a Recalcati, mio compagno a Cantù, poi fui coinvolto nell’euforia generale. Avevo la fiducia dell’allenatore Giancarlo Primo, che mi conosceva bene per precedenti esperienze con la Nazionale militare e con la Nazionale under 18. Lo ricordo come un gran signore, un tecnico esigente e rispettoso; gli devo molto…».

L’anno successivo, ecco la prima Olimpiade, Monaco ’72, quella della strage del commando palestinese. «E già! Alloggiavamo proprio di fronte la palazzina occupata dagli atleti israeliani; fummo svegliati in piena notte dagli spari, e poco dopo ci obbligarono ad abbandonare il villaggio olimpico. Non furono proprio dei bei momenti…». In campo, però, le cose andarono decisamente meglio. «Disputammo un buon torneo e alla fine ci sfuggì il terzo posto nella sfida con Cuba, per una discutibile infrazione di passi di Serafini che aveva schiacciato a canestro il pallone della vittoria…». All’Italia venne negato il bronzo, agli Stati Uniti la medaglia d’oro. «Assistemmo in tribuna a quella incredibile vittoria dell’Unione Sovietica, con i famosi tre secondi finali giocati e rigiocati, e quello a mio avviso fu un vero e proprio furto…». Intanto Marzorati si era messo bene in mostra alla sua prima vetrina mondiale: lo avevano già etichettato come il più americano dei giocatori italiani. Arrivarono subito proposte dai college statunitensi. «Ricevetti un invito da tre Università (Texas, Long Island e un’altra che adesso non ricordo), ma ero troppo attaccato alla mia famiglia e al mio ambiente, e non me la sentii di allontanarmi…».
Buon per la Pallacanestro Cantù, in quegli anni targata «Forst» e affidata alla guida di Arnaldo Taurisano, che già nel novembre del ’69 lo aveva fatto esordire in prima squadra. «Pierlo», come veniva amichevolmente chiamato, era cresciuto nelle giovanili della società brianzola, il suo paese natio era Figino Serenza, lì a un passo. Dalla stagione post-olimpica cominciò l’era dei trionfi: tre vittorie consecutive in Coppa Korac, poi anche il primo scudetto e la prima Coppa Intercontinentale. Il «numero 14» aveva già una sua identità. In Nazionale, nel ruolo di play, si alternava con Giulio Iellini (scuola Milano), caratteristiche così diverse tra loro da offrire un buon assortimento per le scelte in campo dell’allenatore. Arrivò un altro bronzo agli Europei in Jugoslavia, nel ’75, poi la brillantissima qualificazione di Edimburgo alle Olimpiadi di Montreal: Italia prima (battendo anche la Jugoslavia di Cosic), Marzorati premiato come miglior giocatore!

«Eravamo andati in Canada con buone aspettative. Per qualificarci nella finale dei primi quattro, però, ci toccava ancora una volta superare lo scoglio Jugoslavia, e stavolta non riuscimmo a ripetere l’impresa di Edimburgo. Loro erano fortissimi, soprattutto con i cecchini Dalipagic e Delibasic, ma noi buttammo via una vittoria che avevamo già assaporato dopo avere raggiunto un vantaggio di sedici punti. Subimmo psicologicamente l’infortunio di Iellini, anzi lo subii io più di tutti, credo di avere avuto delle responsabilità in quella partita… Alla fine arrivammo quinti, che era sempre un piazzamento di tutto rispetto, ma devo ammettere che allora provai una grande delusione…». Autocritica, sincera, serena: un vero campione si riconosce anche in questo. E dire che in quel torneo olimpico venne nuovamente eletto come miglior giocatore europeo, davanti allo stesso Dalipagic!
Ventidue anni, le presenze in Nazionale erano già più di cento, la sua voglia di migliorarsi sembrava non avere limiti. Non in cerca di soldi o di piazze prestigiose. I risultati importanti li voleva raggiungere a casa sua, a Cantù. Era la volta dei successi in Coppa delle Coppe: tre consecutivi, tra il ’77 e il ’79; il marchio si era trasformato in «Gabetti», lo spirito di questa agguerrita società di provincia era rimasto immutato. Il «bravoragazzo» Pierluigi aveva anche un’altra sfida da vincere: proseguire nello studio fino al traguardo della laurea! Quando indossò per la prima volta la maglia azzurra col titolo di ingegnere si ritrovò tra i convocati del nuovo commissario tecnico, Sandro Gamba. Che attorno a lui e a Meneghin volle costruire il suo ideale di squadra: velocità, intraprendenza e tanta grinta, «…come quella che lui metteva in allenamento e in partita, pretendendo grande impegno da tutti, senza guardare in faccia nessuno!».

Si arrivò così alle Olimpiadi di Mosca ’80. «Conquistammo un argento che ci ripagò di qualche amarezza. La fortuna stavolta fu dalla nostra parte, basti pensare alla partita vinta con Cuba, con lo scarto giusto (non un punto in meno, non uno in più) per approdare nel girone finale col vantaggio acquisito… Però anche grandi meriti da parte nostra: l’impresa di battere l’URSS sul loro campo è qualcosa di indimenticabile. Tutti noi facemmo una grande partita, Meneghin fu addirittura strepitoso. Posso dire che Dino è stato per me sempre da esempio quanto a determinazione, a volontà di pretendere il massimo da se stessi: un vero capitano!». Per la prima volta sul podio olimpico, peccato che in quella occasione non ci fosse il tricolore, ma solo una anonima bandiera a cinque cerchi per via del mezzo boicottaggio politico. «Francamente ci interessava poco della cornice. Eravamo consapevoli del fatto che il basket italiano aveva raggiunto un traguardo storico, e la cosa ci rendeva felici…».
Felici, ma non appagati. Lui sicuramente no! Quell’alloro olimpico avrebbe segnato solo l’inizio di una nuova incredibile serie di vittorie nella sua Cantù. In ordine: il secondo scudetto nella stagione ’81 (in panchina c’era Valerio Bianchini), una Coppa delle Coppe, una Coppa Intercontinentale e, soprattutto, due trionfi consecutivi in Coppa dei Campioni. Nel frattempo la squadra aveva cambiato altri due sponsor («Squibb» e «Ford») e un allenatore: era la volta di Giancarlo Primo, vecchia conoscenza di «Pierlo», ci si poteva intendere solo a sguardi.

Furono quelli gli anni della piena maturità. Sul piano cestistico, Marzorati era diventato un play completo. Non c’era solo eleganza nei suoi movimenti, adesso pure forza atletica; non solo numeri da contropiedista (scatto, elevazione, assist), ma anche organizzazione del gioco; e col tempo, dopo ore lunghissime trascorse in solitario a dialogare col canestro, era riuscito persino a migliorare l’unica arma di cui sembrava difettare un po’, cioè il tiro da fuori. Alla base di tutto sempre la velocità, la sua interpretazione del basket non ammetteva «andamenti lenti»; quel ritmo gli era nato dentro, non poteva reprimerlo. Per questo incantava le platee; per questo i giovani che si avvicinavano al basket, soprattutto i piccoli della sua statura (1 e 87) e giù di lì, cercavano di imitarlo, sognando di diventare un giorno come lui; e intanto, facevano a gara per accaparrarsi la maglia numero 14!
In quel quadriennio interolimpico Marzorati era ancora saldamente al suo posto da titolare nella Nazionale di Gamba, nonostante ci fosse in squadra la concorrenza di altri due play di grande valore, come Roberto Brunamonti e Charly Caglieris. Concorrenza che sortiva buoni effetti, in quel ruolo come in tutti gli altri, e che contribuì a uno dei risultati più importanti mai raggiunti dai colori azzurri, l’oro ai Campionati Europei di Nantes, nell’83. Le credenziali per le Olimpiadi di Los Angeles dell’anno dopo erano cresciute notevolmente. «E invece arrivammo scarichi. Ci mancò quella rabbia, quella cattiveria che avevamo avuto l’anno prima in Francia. L’inizio del torno era stato ottimo: quattro vittorie nelle prime quattro partite; alla resa dei conti, però, con la solita Jugoslavia, mancammo decisamente l’approccio giusto alla partita. Ci riprendemmo in tempo per portare a casa un onorevole quinto posto, ma quella fu, al pari di Montreal, un’altra occasione sprecata per salire sul podio…».

L’avventura olimpica, per Marzorati, finiva là. Non quella in maglia azzurra, che proseguì ancora due anni, fino ai Mondiali in Spagna dell’86: in tempo per conquistare un altro bronzo europeo e per far parte di un nuovo ciclo della Nazionale, con Valerio Bianchini. «Ho avuto sempre un ottimo rapporto con i miei coach, e da ognuno penso di avere tratto insegnamenti importanti. Ricordo soprattutto Taurisano, Primo, Gamba, Bianchini, Recalcati…». Con quest’ultimo, suo ex compagno di squadra, affrontò altre sei stagioni in campionato, raggiungendo quasi sempre buoni piazzamenti nei play-off; poi nel ’91 (il tecnico era Frates, lo sponsor «Clear») l’ennesima coppa Korac, tanto per chiudere in bellezza.
In realtà, l’addio ufficiale venne affidato a una inattesa appendice del 2006, quando il già affermato ingegnere, a 54 anni, decideva di scendere ancora una volta in campo (sempre con la sua Cantù e sempre col suo numero 14) per disputare un paio di minuti nella prima partita di campionato di serie A1 contro la Benetton Treviso. «Quella fu più che altro un’operazione di immagine, per festeggiare i 70 anni della nostra gloriosa società…». La sua, di immagine, in quella occasione destò nostalgia e tenerezza. Quei pochi secondi, tuttavia, gli regalarono altri due primati: diventava il più anziano atleta che avesse mai giocato in un torneo di primo livello in Italia e l’unico ad avere attraversato cinque decenni di attività!
Alla soglia dei 60 anni lo sport è ancora la sua vita. Per impegno professionale e per amore. Nel suo mandato di presidente del CONI Lombardia si intravede la stessa dedizione e lo stesso dinamismo che lo avevano contraddistinto da cestista. «Certi impegni vanno affrontati seriamente, a tempo pieno, altrimenti è meglio lasciar perdere…». Il basket lo segue ancora con interesse. «Per le partite casalinghe di Cantù sono lì, in tribuna; poi c’è sempre a disposizione il ricco programma in TV…». Dove assisterà alle prossime Olimpiadi di Londra. «Peccato che la nostra Nazionale non ci sia, ma sarà comunque uno spettacolo da gustare, basket e non solo… Le Olimpiadi sono davvero un evento straordinario. Posso dire di avere provato emozioni sicuramente superiori a quelle di qualsiasi altra manifestazione sportiva di livello internazionale. Mi viene in mente, tra le altre cose, la cerimonia di inaugurazione, quando ti trovi a sfilare accanto ad atleti di tutto il mondo e di tutte le discipline: sono sensazioni che ti rimangono dentro per sempre…». Detto da uno che le ha provate non una, ma ben quattro volte, c’è proprio da crederci!
Nunzio Spina
[16 – segue Los Angeles 1984, continua con Seul 1988]




