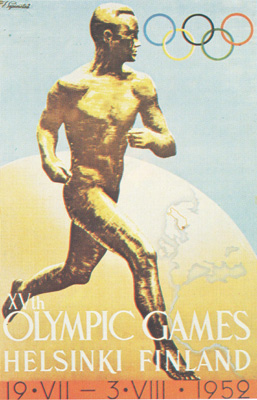Nel segno dell’8… L’orgoglio nazionalistico e le critiche per i diritti umani… Stati Uniti e Spagna protagonisti… La Cina di Yao e l’Argentina di bronzo…

Era l’estate del 2008. Il via venne dato l’8 agosto (ottavo mese del calendario) alle 8 e 08 della sera, quando si accesero le prime luci della cerimonia di apertura dopo che duemilaotto comparse avevano scandito sui tamburi il conto alla rovescia. Nulla di casuale. Per l’Olimpiade di Pechino si cercò di calcolare tutto, cedendo persino alla superstizione popolare che vedeva nel numero «otto» i lineamenti della fortuna.La Cina, in quella circostanza, ne aveva proprio bisogno. Si era messa in gioco davanti agli occhi del mondo intero – che fossero di ammirazione o di invidia – decisa più che mai a imporre il suo nuovo aspetto di paese in rapido e inarrestabile progresso. Ogni cosa andava preparata con attenzione, ogni congiuntura poteva risultare favorevole.
Più che eccezionali, le misure messe in atto dal Comitato Organizzatore si distinsero per la loro originalità. Non servivano solo a dare una dimostrazione di grandezza; dovevano anche permettere di superare ostacoli di ordine pratico. Per reclutare centinaia di migliaia di volontari, in una nazione così popolata comela Cina(1 miliardo e 300 milioni di abitanti), non ci furono problemi; e neanche per allestire un servizio di sicurezza di proporzioni gigantesche, che comprendeva, tra le altre cose, il monitoraggio dei prodotti alimentari. Qualche sforzo andava fatto sul piano della comunicazione: ai poliziotti vennero impartite lezioni di lingue estere, mentre una capillare campagna mediatica invitava la gente di Pechino a mostrarsi ospitale e collaborante con gli stranieri. Ancora più difficile il compito nell’affrontare la questione dell’inquinamento (purtroppo abituale da quelle parti), ma facendo ricorso a leggi speciali il fenomeno fu quanto meno ridimensionato. Conoscere i propri limiti per migliorarsi: di questo, i cinesi, ne avevano sempre fatto una filosofia di vita e di sviluppo.
L’apparato era talmente solido che anche le critiche e i tentativi di boicottaggio nei confronti di un governo oppressore dei diritti umani e religiosi – come da più parti veniva considerato – gli rimbalzarono addosso, senza scalfirlo minimamente. Un grave disagio, per esempio, avrebbe potuto procurarlo l’abbandono dell’incarico di consulente artistico da parte dello statunitense Steven Spielberg (per motivazioni che avevano a che fare con i diritti umani violati): finì invece che la cerimonia d’apertura di quell’8 agosto, con regia e coreografia interamente di marca cinese, e un cast di ben 15.000 persone, risultò la migliore mai prodotta nella storia delle Olimpiadi. Anche perché, a fare da teatro c’era l’imponente e particolarissima sagoma del nuovo Stadio Olimpico, chiamato «Nido d’uccello» per la sua forma, che si rivelò un simbolo di magnificenza e di alta tecnologia.
L’orgoglio nazionalistico non voleva limitarsi al contorno. C’era il proposito – coltivato ormai da anni – di affermarsi come superpotenza anche nel cuore della manifestazione, cioè nell’ambito sportivo agonistico, togliendo magari agli Stati Uniti il primato nel medagliere, che apparteneva loro dalle ultime tre edizioni. I tempi per il tanto agognato sorpasso sembravano maturi. Quarta ad Atlanta ’96, terza a Sidney 2000, seconda ad Atene ’04, la rappresentativa della Cina era ormai praticamente lanciata verso la leadership. Non arrivò il dominio assoluto sul totale delle medaglie (furono ancora gli USA a spuntarla,109 a100), ma tenendo conto solo di quelle d’oro (parametro in base al quale viene solitamente stilata la classifica ufficiale), la vittoria della rappresentativa di casa fu abbastanza netta:51 a36. Una svolta storica!
Gli atleti cinesi, di quadriennio in quadriennio, conquistavano sempre nuovi spazi tra le varie discipline. Sembravano diventati imbattibili nella ginnastica, dove si aggiudicarono il concorso a squadre sia a livello maschile che femminile; dominarono nei tuffi e nel tiro a segno; ottennero successi nel nuoto, nei pesi, nel judo, persino nella scherma, così lontana dalle loro tradizioni. Se si mettevano in testa di riuscire in qualcosa – anche a costo di partire da zero – spesso e volentieri raggiungevano il loro obiettivo. Questione di tempo e di tenacia. La stessa che aveva dato la spinta per il grande e inatteso boom economico. Tutto si poteva costruire, se il regime voleva. Nel caso dello sport, bastava chiudere per giornate intere dei ragazzini dentro una palestra o una piscina, dando loro un unico scopo: diventare competitivi, se non proprio vincenti. A quel punto, poteva effettivamente essere solo questione di tempo!
Un percorso del genere lo aveva compiuto colui che era considerato l’idolo numero uno del popolo sportivo cinese: il cestista Yao Ming. Soprannominato «The gentle giant» («il gigante buono»), per via dei suoi centimetri – ben 229 – e della sua mitezza, era stato concepito come campione forse prima ancora della nascita: il matrimonio dei genitori, entrambi nazionali di basket (il papà 2,01, la mamma 1,90), pare infatti fosse stato in qualche modo incoraggiato dalle istituzioni, proprio al fine di facilitare la nascita di un individuo dotato di qualità fisiche eccezionali. Il progetto riuscì a tal punto che a soli 22 anni Ming fu chiamato negli States come prima scelta NBA degli Houston Rockets, trasferimento che finì con l’aumentare la popolarità nel suo paese, per il quale continuò a difendere i colori e a promuovere iniziative umanitarie. Ai Giochi di Pechino vollero che fosse ancora lui, dall’alto delle sue braccia, a sostenere la bandiera rossa della Cina nella cerimonia di apertura, così come era già accaduto quattro anni prima ad Atene; una replica che destò ancora più sensazione, perché al suo fianco fecero sfilare un bambino sopravvissuto al terremoto che aveva recentemente colpito una regione dello stato asiatico. Fu uno dei tanti effetti originali che arricchì quella cerimonia d’apertura!
Con la presenza di Yao Ming il torneo di basket maschile si ritrovò, più che mai, al centro dell’attenzione. La passione cestistica in Cina era in continuo aumento da quando la Nazionaleaveva iniziato la sua lunga e ininterrotta serie di partecipazioni olimpiche, da Los Angeles ’84 in poi. Grazie al «gigante buono», che aveva esordito a Sidney 2000 all’età di 20 anni, la crescita era stata esponenziale negli ultimi tempi, e sul suo carisma adesso si puntava per questo importante appuntamento casalingo. Una «frattura da stress» al piede (infortunio che svelava una debolezza nel suo imponente fisico e che già altre volte lo aveva costretto a dei lunghi stop) stava per lasciarlo fuori dalla competizione, poi riuscì a recuperare stringendo i denti, con sollievo di tutti, compreso il presidente della Repubblica Popolare di Cina, Hu Jintao, che fino all’ultimo si era personalmente interessato delle sue condizioni di salute. La sera del 10 agosto, il Wukesong Indoor Stadium (impianto di 18.000 posti, appositamente costruito negli ultimi tre anni) si riempì in ogni ordine di posto per la partita d’esordio contro gli Stati Uniti. Una festa comunque, al di là dell’annunciata sconfitta (forse più netta del previsto,101 a 70), anche perchè con 13 punti realizzati e 10 rimbalzi conquistati, Ming era stato all’altezza (in tutti i sensi) dei suoi colleghi NBA.
La squadra cinese si classificò ottava alla fine, dopo avere guadagnato l’accesso ai quarti e col rammarico di avere ceduto solo al supplementare alla fortissima Spagna. Ming quasi sempre top-scorer (30 e 25 punti rispettivamente nelle partite vinte con Angola e Germania) e sempre in bella evidenza: aveva onorato l’impegno come meglio poteva, e per il pubblico di casa andava bene così. Furono altri, naturalmente, i veri protagonisti di quel torneo. Gli Stati Uniti innanzitutto, che si riappropriarono della medaglia d’oro alla loro vecchia maniera, cioè con un percorso netto di tutte vittorie, 28 punti di scarto medio. Non un «Dream Team», ma un «Redeem Team» («Squadra della Redenzione»), perché bisognava a tutti i costi riscattarsi dal deludente bronzo di Atene, oltre a quello degli ultimi Campionati Mondiali del 2006 in Giappone. Dopo essersi sbarazzati degli avversari nel turno di qualificazione (la Cina, l’Angola,la Grecia,la Spagna ela Germania), i cestisti statunitensi approdarono alla finale per l’oro superando altrettanto agevolmente l’Australia ai quarti (116-85) e l’Argentina in semifinale (101-81), una rivincita, quest’ultima, meditata per quattro anni.
Ogni qual volta il basket statunitense mancava il successo in una competizione internazionale, si faceva ricorso a provvedimenti speciali. Come quello di impostare un programma a lunga scadenza e, se il caso, di offrire alla selezione maggiori opportunità di misurarsi in tornei amichevoli. Stavolta il compito venne affidato, con due anni di anticipo, a Mike Krzyzewski, uno degli allenatori più in vista della NCAA, il campionato dei colleges universitari. Ricostruì la squadra attorno alla guardia Dwyane Wade e alle ali piccole Carmelo Anthony e LeBron James, che ad Atene – ancora giovani rampanti – non avevano espresso tutto il loro valore. Si affidò poi all’esperienza del trentacinquenne play Jason Kidd, che era stato artefice dell’oro di otto anni prima a Sidney, e alla stazza fisica del giovane Dwight Howard, centro di 2 e 11. L’inserimento più importante, tuttavia, si rivelò quello di Kobe Bryant, guardia tiratrice di 1,98, atteso già da tempo sulla scena olimpica. Aveva ormai 30 anni, la superstar dei Los Angeles Lakers, con i quali aveva conquistato il three-peat, tre titoli consecutivi dal 2000 al 2002. Portava qualcosa di italiano dentro, in quanto figlio di Joe Bryant, che dall’84 al ’91 aveva militato nel nostro campionato: se lo ricordano ancora – a Rieti come a Reggio Calabria, a Pistoia o a Reggio Emilia – quando, ragazzino, Kobe cominciava a prendere confidenza col pallone da basket, entrando sul parquet a conclusione delle partite di papà. A Pechino, con i suoi canestri e i suoi assist, rappresentò quel tocco di classe in più per fare di un insieme di ottimi giocatori una squadra imbattibile.
La protagonista numero due fu la Spagna, squadra che da diversi anni si era assestata ai vertici del basket mondiale, sulle orme di un altro gigante cresciuto in casa e poi «requisito» dalla NBA: Pau Gasol, centro di 2 e11 dal fisico armonioso, cattura-rimbalzi, buon tiratore dalla media distanza. La Nazionale iberica aveva trionfato ai Mondiali del 2006 e si era confermata l’anno successivo con l’argento agli Europei: era molto attesa a Pechino, anche perché nelle sue ultime partecipazioni olimpiche la fortuna non l’aveva certo assistita. Oltre a Gasol, l’allenatore Aito Garcia Reneses (un palmares ricco di successi col Barcellona) poteva disporre di molte altre individualità di spicco: la guardia Juan Carlos Navarro (compagno di squadra di Gasol a Memphis), l’ala grande Jorge Garbajosa (in forza ai Toronto, dopo qualche stagione giocata a Treviso), il play Ricky Rubio, l’ala piccola Carlos Jimenez, il centro Felipe Reyes; c’era anche Marc Gasol, fratello di Pau (5 anni più piccolo,3 centimetri più alto), che subito dopo Pechino avrebbe preso nella NBA il posto del fratello, mentre questi si trasferiva a Los Angeles.
Stavolta la Spagna ebbe la fortuna – si fa per dire – di incontrare gli Stati Uniti nel girone eliminatorio: rimediò quasi 40 punti di scarto (119 a 82), ma quell’unica sconfitta, quanto meno, non arrestò il suo cammino. Ai quarti fece fuori la Croazia (72 a 59), in semifinale riuscì a rimontare controla Lituania (91 a86), con Pau Gasol autore di una ventina di punti in entrambi i casi. Approdava così alla sfida per l’oro, e la gioia di essere comunque tornati sul podio, dopo il lontano argento di Los Angeles ’84, le diede la carica per affrontare nuovamente i fuoriclasse statunitensi senza alcun timore. Ne venne fuori una finale memorabile, se non altro per il risultato finale che rappresentava un record come totale di punti segnati: 118 a107, infavore degli USA come sappiamo. La Spagna non aveva avuto solo il merito di realizzare tanti canestri e di limitare il passivo, ma era stata in grado di condurre in vantaggio per lunga parte dell’incontro (38-31, 69-61, 91-82 i parziali). Miglior realizzatore era stato Dwyane Wade (27 punti, con un 9/12 al tiro), ma forse il giocatore determinante per la vittoria risultò Kobe Bryant, che nell’ultimo quarto realizzò 11 dei suoi 20 punti.
Aveva ancora ambizioni di medaglia la Nazionale argentina che ripresentava gran parte degli eroi di Atene ’04 (da Manu Ginobili a Carlos Delfino, da Andres Nocioni a Luis Alberto Scola), con qualche inserimento interessante, come quella del playmaker Pablo Prigioni, affermatosi nel campionato spagnolo. Nella finale per il bronzo i sudamericani ebbero nettamente la meglio sulla Lituania, nelle cui file militavano giocatori del calibro di Siskauskas, Jasikevicius e Kaukenas (in forza quest’ultimo a Siena, artefice degli ultimi due scudetti). Per l’Argentina un risultato comunque di prestigio, che rafforzava la sua posizione ai vertici mondiali;la Lituania masticava amaro dopo aver mancato il podio olimpico per la seconda volta consecutiva, ma tre medaglie di bronzo e due quarti posti da quando (Barcellona ’92) aveva intrapreso il suo cammino indipendente dall’ex URSS, era comunque un importante segnale di continuità.
Nunzio Spina
[26 – segue l’intervista a Recalcati, continua con la seconda parte di Pechino 2008]