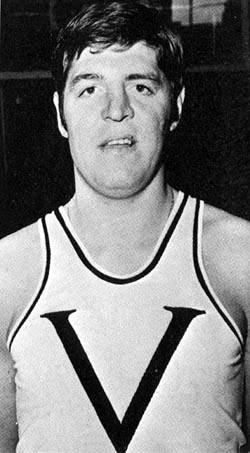Yoshinori Sakai, il tedoforo sconosciuto… Sudafrica e Cina, grandi assenti… Nazionale di basket: si raccolgono i frutti di Paratore… La beffa polacca… Esordio della pallavolo…

Un filo di sentimenti legava Tokyo a Roma. A quattro anni di distanza era la volta di un altro paese vinto e sconvolto dalla Seconda Guerra Mondiale a cogliere l’occasione di un’edizione olimpica per festeggiare la propria rinascita. In Giappone c’erano state anche le bombe atomiche ad aumentare le sofferenze. E per cancellare quel triste passato venne affidato a un diciannovenne sconosciuto, tale Yoshinori Sakai, il compito di accendere il braciere olimpico come ultimo tedoforo: era nato a Hiroshima, un’ora dopo lo scoppio della prima bomba atomica; simboleggiava una nuova vita e la voglia di pace.
Se Roma aveva incantato il mondo con il suo magnifico sfondo di storia, Tokyo lo stupì con la sua efficienza e la sua tecnologia. L’imperatore Hirohito, che il 10 ottobre diede il via ai Giochi dalle tribune coperte del nuovo Stadio Olimpico, accettò di destinare una somma ingente per l’allestimento di tutte le strutture necessarie. Nulla venne lasciato al caso; persino le bandiere delle varie nazioni – in assenza di vento o negli impianti chiusi – sventolavano sotto l’azione di apparecchi a batteria. Il progresso, d’altronde, andava avanti veloce in quegli anni; la stessa TV aveva allargato i suoi orizzonti, e adesso si serviva di un satellite per raggiungere tutto l’Emisfero Nord, Stati Uniti compresi.

Purtroppo, nel mondo tornavano a soffiare venti di odio e di conflitti. Il Sudafrica, con le sue leggi di segregazione razziale, si guadagnò lo sdegno di tutti, non solo del Continente Nero: il CIO gli negò l’invito. Poi c’era il solito isolamento della Cina Popolare di Mao, che stavolta si trascinò nell’esclusione anche la Corea del Nord e l’Indonesia. Situazioni che crearono problemi, ma il futuro avrebbe riservato di peggio. In compenso ci fu un nuovo record di paesi partecipanti (93), anche in virtù della acquisita indipendenza di molte ex colonie. Gli atleti in totale furono meno di Roma, ma a Tokyo influirono la lontananza dall’Europa e ancora una volta la stagione autunnale, come era accaduto a Melbourne. La selezione italiana si limitò a 170 atleti, di cui solo 11 donne; tra le poche rappresentative negli sport di squadra, quella del basket rispose ancora presente.
La Nazionale di Paratore era rimasta un po’ inebriata dall’inatteso quarto posto delle Olimpiadi Roma. Al punto da rinunciare – chissà se per un meritato riposo o per timore di una pronta ricaduta – agli Europei dell’anno successivo in Jugoslavia. Per un po’ di tempo ci si affidò nuovamente a raduni collegiali e a una lunga serie di amichevoli, dove l’inserimento di nuovi giocatori poteva liberarsi dall’assillo del risultato. Il ’63 fu una stagione piena di impegni ufficiali: la prima partecipazione ai Campionati Mondiali (si disputarono in Brasile e arrivò un buon settimo posto), i Giochi del Mediterraneo (li ospitava Napoli, fu conquistato un oro che non si poteva proprio mancare) e di nuovo gli Europei, in Polonia a Wroklaw (dodicesimi, ma con una formazione priva di nove titolari o presunti tali). L’obiettivo principale, in realtà, erano ancora le Olimpiadi; il resto solo tappe di avvicinamento. Basti pensare che in quelle tre competizioni, più di dieci giovani reduci dal famoso raduno di Fermo del ’57 avevano fatto il loro debutto in prima squadra: Gatti, Cescutti, Bertini, Dal Pozzo, poi Bufalini, Velluti, Cosmelli, Rossi, infine Pellanera, Masini, Flaborea.

Il quarto posto di Roma aveva garantito la qualificazione a Tokyo, e quindi ci si poteva permettere di fare tutti gli esperimenti possibili. Però era anche un piazzamento da onorare, e in molti si era insinuato il sospetto – per alcuni si trattò di una maliziosa convinzione – che la Nazionale azzurra, a Roma, avesse tratto eccessivo vantaggio dal fatto di giocare in casa, realizzando così un’impresa irripetibile. Paratore doveva guardarsi anche da queste critiche; finì col ripetere l’esperienza pre-olimpica della tournée, lontano quanto bastava da certi condizionamenti. Stavolta scelse gli Stati Uniti, impegnando la squadra in un lungo giro per i Colleges: non proprio un viaggio di piacere.
Alla fine prevalsero in lui, come sempre, equilibrio e senso pratico. Per Tokyo confermò sette elementi della formazione che aveva acceso gli entusiasmi di Roma (Gavagnin, Vianello, Pieri, Sardagna, Vittori, Giomo, Lombardi), mentre dei tanti giovani provati e riprovati ritenne che soltanto cinque avessero la maturità per affrontare un impegno internazionale così importante. Erano Ottorino Flaborea (ottimo difensore, raccoglieva l’eredità di Calebotta nel tiro a uncino), Gianfranco Bertini (che si era messo in luce a Pesaro, detto «il ragno» per le sue capacità atletiche), Sauro Bufalini (pivot di due metri, faceva coppia con Gavagnin a Varese), Giusto Pellanera (originario di Teramo, una guardia con doti di contropiedista), Massimo Masini (2 e 08, il primo vero gigante azzurro; il Simmenthal Milano lo aveva prelevato ancora quindicenne a Montecatini Terme, quasi strappandolo alla famiglia). Milano e Varese erano i club più rappresentati, e non a caso: negli ultimi quattro anni l’Ignis aveva preso il posto di Bologna nel contendere lo scudetto al Simmenthal, riuscendo a sottrarglielo nel ’61 e nel campionato appena concluso.

Al basket fu destinato il Palazzo dello Sport dello Yoyogi National Gymnasium, un complesso polivalente comprendente anche la Piscina Olimpica. I due impianti, con la loro avveniristica copertura a tensostruttura, sospesa a dei piloni, erano stati creati dal genio dell’architetto Kenzo Tange (famoso poi anche in Italia per alcune sue opere, tra cui la progettazione del quartiere Librino di Catania). Il torneo si disputò con una formula differente rispetto alle edizioni precedenti: due soli gironi nei quali erano suddivise le solite sedici squadre partecipanti; al termine della lunga fase di qualificazione di sette partite per ognuno, soltanto le prime due accedevano alla semifinale. Una selezione sicuramente più dura. C’erano USA, URSS e Brasile (le prime tre di Roma ’60), e poi Jugoslavia, Polonia e Ungheria sul fronte europeo, Portorico, Messico e Uruguay su quello americano, oltre al Giappone.
L’Italia cominciò bene. Vittorie con Messico (85 a 80) e Portorico (74 a 64), nelle cui file giocava il «duemetri» Teofilo Cruz, già presente a Roma e poi in ben tre Olimpiadi successive. Poi una battuta d’arresto con la Polonia, di soli tre punti (58 a 61), uno scarto che avrebbe avuto, qualche giorno dopo, l’amaro della beffa. Ma si poteva ancora sperare, e il morale tornò subito alto grazie ad altri due successi: con Canada (66 a 54) e Ungheria (77 a 73). A quel punto c’era il Giappone da superare. La partita fu giocata alle 8 di mattina, un orario che per le italiche abitudini sportive voleva dire notte fonda: loro, vispi, scattavano come furetti, gli azzurri ci misero un po’ prima di svegliarsi, e alla fine dovettero soccombere (68 a 72). Fu l’addio alla qualificazione, perché con l’Unione Sovietica, testa di serie, non si poteva certo pretendere di fare il miracolo, anche se poi la sconfitta (67 a 76) si rivelò tutt’altro che pesante.
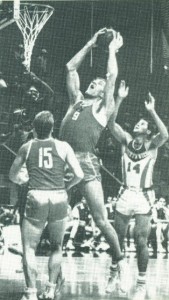
Fuori dai primi quattro posti, dunque; con grande rammarico di Paratore e dei suoi, che addirittura videro entrare in semifinale – per una strana combinazione di risultati – il Portorico, già battuto di dieci punti. La beffa di cui si parlava sarebbe arrivata dopo. Nel girone per l’assegnazione dei posti dal 5° all’8°, dopo avere battuto la Jugoslavia (75 a 63), l’Italia si trovò nuovamente di fronte la Polonia: i 20 punti di passivo inflitti agli avversari (79 a 59) fecero solo aumentare la rabbia per quella sconfitta di misura subita in qualificazione.
Comunque quinti! Dopo il quarto posto di Roma, maturato secondo alcuni solo grazie all’aiuto del pubblico e di chissà quale altra forza soprannaturale, questo risultato di Tokyo andava assolutamente considerato come una brillante conferma. Il basket italiano era ancora lì, tra le grandi, con un suo gioco e una sua identità. Anzi soltanto allora – trascorso qualche anno dall’inizio del suo mandato – si poteva apprezzare veramente la bontà del lavoro di Paratore. E intanto ci si era assicurati la qualificazione al successivo torneo olimpico.
Gli Stati Uniti confermarono il loro predominio, conquistando l’oro con una lunga serie di sole vittorie. Qualche problemino solo con la Jugoslavia (69 a 61), formazione che cominciava a crescere di livello; per il resto, 25 punti minimo di scarto a tutte le avversarie. In finale l’Unione Sovietica ci provò a rendere la vita difficile, col ciclopico Janis Krumins (alla sua terza edizione olimpica), ma non andò al di là di un onorevole 59 a 73. Terzo si confermò il Brasile, che dopo aver fatto faticare l’URSS batté nella finale per il bronzo il Portorico.

Il giocatore più rappresentativo della squadra statunitense era Bill Bradley, una guardia-ala mancina di 1 e 96, ottimo difensore, creatore di gioco e realizzatore di grande valore. Era sorretto da una dote davvero singolare, quella di un campo visivo – fu provato scientificamente – ben oltre i 180 gradi, che rappresentano la media della popolazione: per cui era in grado di eseguire tiri e passaggi assolutamente imprevedibili. Capitano di quella squadra, da lì a poco avrebbe vestito la maglia del Simmenthal come straniero nelle competizioni europee, contribuendo alla conquista della Coppa dei Campioni nel 1966, vinta a Bologna contro lo Slavia Praga. Intraprese poi anche la carriera politica, fino a diventare Senatore degli Stati Uniti.
L’oro nel basket contribuì stavolta al primo posto assoluto degli americani nel medagliere, dopo due edizioni concluse alle spalle dei sovietici. Gli USA era tornati a primeggiare nell’atletica leggera, con la nuova invasione dei velocisti neri, tra cui Hayes (10 e 06 nei 100, rimasto il miglior tempo di sempre nelle piste non sintetiche), e con il terzo oro in tre Olimpiadi consecutive del discobolo Al Oerter. Man bassa di medaglie anche nel nuoto, dove un giovane del North Carolina di origini svedesi, Don Schollander, si mise al collo ben 4 ori, dopo avere inventato la virata a capriola nello stile libero, toccando il bordo con i piedi e non più con la mano.
Lo Stadio Olimpico applaudì anche altre imprese. Come quella di Abebe Bikila, che rivinse la maratona, stavolta concludendo la sua gara in pista, e con le scarpe ai piedi. O quella del saltatore in alto sovietico Valerij Brumel, uno dei migliori interpreti nella storia dello scavalcamento ventrale: vinse l’oro e toccò il cielo con un dito, ignaro dell’amaro destino che lo attendeva l’anno dopo, vittima di un incidente di moto dal quale uscì con una gamba spezzata in più punti e poi in preda a una osteomielite; ce l’avrebbe fatta – dopo diversi anni e ben 37 interventi chirurgici – a tornare sulla pedana del salto in alto, vincendo così la sfida più importante della sua vita.

Fece il suo debutto la pallavolo, che vide prevalere il Giappone nella competizione femminile: prime immagini di atlete di statura limitata ma dalle incredibili doti di saltatrici, un mito che avrebbe poi invaso anche il mondo dei cartoni animati. C’erano discipline in cui i padroni di casa non potevano fallire: come la ginnastica maschile (5 primi posti su 8 gare) o il neo-introdotto judo (3 ori su 4, ma quello sfuggito a favore di un olandese, nella categoria «open», fece nascere quasi un caso di stato). Alla fine il Giappone realizzò il classico exploit del paese organizzatore: terzo posto nella classifica finale, come era successo in precedenza all’Australia e all’Italia. In più, la gente dagli occhi a mandorla aveva ammaliato con i suoi modi gentili, distribuendo sorrisi e inchini a tutti: un successo anche questo, di ospitalità e di simpatia.
La spedizione azzurra se la cavò egregiamente, nonostante il ridotto numero di partecipanti. Fatte le debite proporzioni, le 10 medaglie d’oro, 10 d’argento e 7 di bronzo, pesavano quanto le 36 di Roma. Quinto posto, come il basket: non si poteva pretendere di più. Ancora un buon bottino nel ciclismo e nel pugilato. Sorprendente l’oro del ginnasta Gianni Menichelli nella prova a corpo libero, davanti ai maestri giapponesi; mentre il giovane Klaus Dibiasi cominciava la sua epopea olimpica nei tuffi, con l’argento nella piattaforma. Ancora più emozionante (oltre che curiosa) la vittoria di Abdon Pamich nella 50 km di marcia: al 38° chilometro di una gara durissima, disputata sotto una pioggia battente, ebbe una crisi intestinale dopo aver bevuto una bevanda fredda; Pino Dordoni, il medagliato di Helsinki ’52, lo incitava inutilmente perché lui non riusciva ad andare avanti; provvidenziale una siepe ai lati della strada dove si ritirò un attimo per il suo bisogno fisiologico; poi, liberato dal peso, riuscì ad arrivare solitario al filo del traguardo, che strappò con entrambe le mani: un gesto per scaricare anche la sua rabbia.
Nunzio Spina
[7 – segue la seconda parte di Roma, continua con Città del Messico 1968]